
Storia e memoria della Russia sovietica nella Russia di Putin

Masha Gessen, Misha Friedman, Never Remember. Searching for Stalin’s Gulags in Putin’s Russia, Columbia Global Reports, New York 2018.
Anche le cose minori sono meritevoli di attenzione, ma diventano minime di fronte alla grandezza tragica e alla miseria grottesca del “comunismo storico”, un tema, questo, oggi per lo più rimosso o censurato per complicità o insipienza, mentre è centrale per la storia del XX secolo.
Vittorio Strada, Lenin, Stalin, Putin. Studi su comunismo e postcomunismo, Rubettino, Soveria Mannelli 2011, p. 12.
Scheletri nella foresta di Sardarmok in Carelia
Luglio 1997. Irina Flige e Veniamin Iofe presero un treno notturno da San Pietroburgo a Medvezhya Gora (dal 1938 Medvezhegorsk), nella Repubblica di Carelia, dove avrebbero potuto disporre dell’aiuto di un reparto di reclute accampate nelle vicinanze. A loro si era unito Yuri Dmitriev, capo della Memorial Society di Petrozavodsk capitale della Carelia.
Cercavano di ritrovare il luogo dove erano stati sepolti in gran segreto oltre mille prigionieri delle isole Soloveckie trucidati nel novembre del 1937 per ordine del governo sovietico. Sapevano dunque che cosa cercare e anche dove, ma solo con qualche approssimazione; il luogo doveva trovarsi ad una ventina di chilometri da Medvezhya Gora e vicino al villaggio di Pindushi, sul lago Onega.
Si misero tutti a battere la foresta e i soldati a scavare delle buche profonde, sulle prime senza risultati. Fu Dmitriev a richiamare l’attenzione sulla strana conformazione del terreno in un tratto tra le betulle: delle ampie depressioni di forma rettangolare si alternavano regolarmente con tratti sopraelevati. I locali conoscevano il luogo, Sandarmokh, frequentato dai cercatori di funghi, ma attribuivano le depressioni all’effetto delle bombe sganciate durante la seconda guerra mondiale.
I soldati presero a scavare all’interno dei rettangoli, ma quando arrivarono a 180 cm circa di profondità, balzarono improvvisamente fuori: avevano appena disseppellito delle ossa e non avevano intenzione di proseguire. Flige si calò in una delle fosse e cominciò a liberare accuratamente i resti dal terriccio: erano ossa umane di diversi scheletri impilati gli uni sugli altri, mentre i crani, orientati nella stessa direzione, avevano tutti un foro come procurato da una pallottola. Tra le betulle, a Sandarmokh, Flige, Iofe e Dmitriev contarono poi 236 fosse.
Cos’era accaduto?
Una lunga ricerca. Dalle Soloveckie a Sandarmokh
Flige e Iofe lo sapevano. E vi erano arrivati magari fortunosamente, ma seguendo ostinatamente una traccia. Nel 1989, Veniamin Iofe, ex prigioniero politico e dissidente, e la sua assistente, Irina Flige, membri della Memorial Society di San Pietroburgo, avevano guidato un gruppo di persone, prevalentemente donne di mezza età, dirette alle isole Soloveckie, dove erano stati prigionieri e dove erano stati uccisi i loro congiunti. Era una manifestazione organizzata nell’ambito dei Giorni della memoria delle Soloveckie.
Sul treno che portava il gruppo a destinazione, Iofe aveva avuto modo di esaminare i certificati di morte dei genitori che i partecipanti avevano portato con sé e aveva notato che in una quindicina di casi le date del decesso erano tutte collocate all’interno di una stessa settimana dell’autunno 1937. «Si tratta di un’esecuzione di massa», concluse Iofe.
Entrambi sapevano che il campo delle Soloveckie era stato chiuso nel 1937 e che i prigionieri erano stati trasferiti altrove, molti però erano stati uccisi sulla terraferma non lontano dalle isole. Ma dove?
Flige e Iofe, non erano accademici né ricercatori accreditati e non avevano alcun titolo per accedere agli archivi per verificare l’ipotesi di una esecuzione di massa dei prigionieri delle Soloveckie. Ma un primo serio indizio venne loro nei primi anni Novanta da un ex archivista del FSB – sigla dell’organismo erede del KGB –, il quale, risentito per essere stato licenziato, aveva portato con sé documenti dai quali risultava che alcune troike (commissioni giudicanti di tre membri che pronunciavano sentenze inappellabili, anche capitali, in assenza degli imputati) avevano emesso i loro verdetti morte alle Soloveckie proprio nell’autunno del 1937.
Un secondo indizio venne recuperato qualche anno dopo, a metà degli anni Novanta; si trattava di un documento del KGB di Leningrado dove era riportato l’ordine di evacuazione di alcune centinaia di prigionieri delle Soloveckie nell’autunno 1937, da effettuarsi sotto la responsabilità del capitano Mikhail Matveev. Nel documento c’era anche un riferimento a Medvezhya Gora, capitale del Gulag dove negli anni Trenta erano stati internati i forzati della costruzione del canale del mar Bianco-mar Baltico.
Nel 1996 venne recuperato un altro indizio dal libro di un ufficiale della polizia, dove era nominato un certo Mikhail Matveev, presumibilmente lo stesso del documento di Leningrado, insignito prima di un’onorificenza e poi arrestato per abuso di potere.
Anche se non avevano libero accesso agli archivi, Flige e Iofe, come rappresentanti di un’organizzazione non governativa, potevano chiedere di leggere il fascicolo relativo al capitano Metveev. Cosa che fecero e che richiese diversi giorni di lavoro sorvegliato in archivio, al termine del quale riuscirono però a ricostruire la storia.
Sequenza di morte
A Matveev era stato ordinato di evacuare dalle Soloveckie 1116 prigionieri per eseguire la relativa condanna a morte, dove non era esplicitamente indicato, ma si faceva riferimento al «solito luogo». Dalle Soloveckie i prigionieri furono trasferiti in alcune baracche nei dintorni di Medvezhya Gora, dove, il 27 ottobre 1937, ebbe inizio il massacro così raccontato dalla Gessen: Matveev, che poteva disporre di un solo camion e di una vettura, cominciò il 27 ottobre portando una ventina di prigionieri sul luogo dell’esecuzione sul camion, che ne poteva contenere sedici, mentre le donne vi venivano portate con l’automobile. Quel primo giorno, uno dei prigionieri riuscì a slegarsi, e tentò di scappare. Matveev e i suoi aiutanti lo bloccarono ed eliminarono i prigionieri come programmato. Ma l’incidente li aveva messi in difficoltà. Matveev bloccò le esecuzioni e nei giorni seguenti continuò a bere e a pensare a come portare a termine l’operazione. Il lavoro riprese il 1° novembre, quando Matveev mise a punto una nuova procedura che prevedeva il passaggio dei detenuti in tre stanze diverse: nella prima venivano identificati sulla base di un elenco e perquisiti, nella seconda venivano legati mani e piedi, nella terza venivano tramortiti con un colpo alla nuca sferrato con una grossa mazza di legno.
I prigionieri così tramortiti potevano essere ammucchiati nel camion, che, in tal modo, poteva arrivare a contenere quaranta corpi. Il mucchio veniva coperto con un telone, mentre sopra si sistemavano Matveev e i suoi aiutanti, pronti a colpire con la mazza chi avesse ripreso conoscenza. Sul luogo dell’esecuzione vera e propria, i prigionieri venivano gettati nelle fosse e Matveev provvedeva a finirli con un colpo di pistola in testa.
La nuova procedura si mostrò efficace e Matveev il 4 novembre poté esaurire il compito assegnatogli, mentre il rapporto finale ai superiori venne consegnato il 10 successivo: aveva eseguito 1111 sentenze di morte, un prigioniero era deceduto prima dell’esecuzione e quattro erano stati trasferiti in un’altra prigione.
Matveed aveva riportato tutto con precisione, salvo il luogo dell’esecuzione. Ecco perché Flige e Iofe conoscevano i fatti che avevano portato alla morte di 1111 prigionieri, ma non esattamente il luogo in cui erano stati sepolti.

Fig. 2 – Sandarmokh. Il luogo dell’eccidio. By Semenov.m7 – Own work, CC BY-SA 3.0, Link
Che fare?
Ma, ora che le fosse erano state individuate, che fare? Che fare dei miseri resti di 1111 uomini e donne trucidati sessanta anni prima su ordine del potere sovietico? Furono coinvolti, e non poteva essere altrimenti, la Procura, la Guardia forestale, le amministrazioni locali. La procura propose di utilizzare la locuzione “esecuzione multipla” invece di “esecuzione di massa”, come invece sosteneva Flige.
Il governo regionale decise di costruire una strada e un monumento commemorativo. L’artista che venne incaricato di progettarlo decise di mantenere le assi di legno verticali, che Flige e Iofe avevano piantato in capo ad ogni fossa con un numero, e di aggiungervi solo un tettuccio a timpano. Sarebbero poi state utilizzate dai familiari per scrivervi i nomi degli uccisi: potevano essere considerate quanto di più simile ad un monumento individuale. La locale chiesa ortodossa fece erigere una cappella e altrettanto fece la chiesa cattolica. Il governo regionale fissò per il 27 ottobre 1997 – sessantesimo anniversario dell’inizio del massacro – una cerimonia di commemorazione.

Fig. 3 – Sandarmokh. Il luogo dell’eccidio. Immagine tratta da Never Remember. Searching for Stalin’s Gulags in Putin’s Russia, Columbia Global Reports, New York 2018.
Alla cerimonia parteciparono con appositi discorsi le autorità locali e i rappresentanti delle chiese ortodossa e cattolica. Erano presenti numerosi uomini e donne, figli e nipoti delle migliaia di prigionieri che avevano sofferto ed erano morti per mano del governo sovietico negli anni Trenta. Alcune donne in scialle nero ruppero la fredda ufficialità della cerimonia scoppiando a piangere e torcendosi le mani al ricordo degli anni di pena, rabbia e paura. Altri cominciarono a scrivere sulle assi quei nomi che loro non avevano mai dimenticato. Nei giorni successivi, sugli alberi cominciarono ad essere affisse fotografie delle vittime, un modo per riaffermare l’umanità, l’individualità, l’appartenenza ad una famiglia di uomini e donne, che il terrore sovietico aveva cercato di annullare nel massacro collettivo anonimo e segreto.
In ogni caso, era la prima volta che su un sito di esecuzioni di massa veniva eretto un monumento commemorativo con riconoscimento ufficiale, delle autorità locali almeno.
Che cosa ricordare? Perché ricordare?
Dal punto di vista delle autorità, e dunque dello Stato che aveva sostituito la dittatura sovietica, erano in gioco problemi rilevanti e complicati, che riguardavano le forme del riconoscimento e del ricordo pubblico di strutture, fatti ed eventi che avevano caratterizzato profondamente lo Stato e la società sovietica e comunista per oltre 70 anni: Gulag, terrore, massacri di massa, processi senza giustizia, deportazioni.
La glasnost, negli anni Ottanta, aveva permesso l’apertura degli archivi e la pubblicazione delle memorie di ex prigionieri, ma la dissoluzione dell’Urss nel 1991 aveva portato l’opinione pubblica ad abbandonare la ricerca sul passato per concentrarsi sul traumatico e drammatico presente, mentre i gruppi di potere erano convinti la ricerca di ciò che era accaduto poteva avere esiti esplosivi. Cosa sarebbe infatti accaduto se il popolo avesse scoperto che i propri genitori erano stati denunciati, imprigionati, torturati, uccisi dai vicini di casa o dai loro parenti? Per il governo dunque era più utile andare avanti senza interessarsi del passato e continuare a mantenere il controllo degli archivi tramite la polizia politica.
E infatti, la scoperta delle fosse di Sandarmokh fu dovuta ad una catena di fortunati ritrovamenti.
Negli anni dell’apertura erano nate molte Memorial Societies che si proponevano di scoprire i fatti dell’era sovietica e di sollecitare prima un confronto pubblico e poi un ricordo condiviso. Da questo punto di vista risultava davvero significativa la composizione del gruppo di Dmitriev: egli, in primo luogo, non era figlio né di una vittima né di un aguzzino, cosa abbastanza inusuale rispetto alla generalità dei casi; ma un suo compagno di ricerca, Ivan Chukhin, era figlio di un esponente del NKVD implicato nel terrore, mentre un altro, Pertti Vuori, aveva avuto il padre ucciso in Carelia proprio dal NKVD. Un gruppo dunque composto dal figlio di una vittima, dal figlio di un aguzzino e da un terzo senza legami familiari col terrore.
Il diffondersi delle Memorial societies e la scoperta delle fosse di Sandarmokh potevano lasciar sperare che il resto dei milioni di uccisi, deportati, torturati nei Gulag dell’ex impero sovietico avrebbero avuto i loro monumenti, i loro musei, la ricostruzione delle loro storie. Non è andata così. Il monumento di Sandarmokh è rimasto un’eccezione e il processo di costruzione di una memoria collettiva e pubblica è stato bloccato giusto all’inizio.
Sandarmokh non ha un custode e si è nel tempo trasformato in un monumento affidato alle cure spontanee di singoli e gruppi che continuamente lo creano e lo ricreano portandovi croci, pietre, targhe, scritte, fotografie, corone. La parola “memoria” è quella più frequente. Ma il cartello sulla strada A-119 indica semplicemente “Cimitero”, nessun’altra indicazione sulla natura e sul significato del sito per l’eventuale ignaro viaggiatore.
Storia e memoria nell’era di Putin
Masha Gessen incontrò Irina Flige nel 2016, quasi venti anni dopo Sandarmokh, perché stava scrivendo un libro per cercare di capire come mai in Russia si era preferito dimenticare piuttosto che ricordare. Flige obbiettò che si sbagliava: non c’era in atto alcun processo di oblio, per il semplice fatto che non c’era mai stato, in realtà, alcun serio processo di costruzione di una memoria pubblica: «Eravamo convinti di star costruendo una memoria storica. Ma la memoria storica può esistere solamente se vi è una chiara linea di separazione tra il passato e il presente. Come accade quando si dice “Dopo l’Olocausto”. Ma da noi non c’è questa rottura, non c’è un passato, solo un presente continuo. Così, noi abbiamo a che fare più con una eredità che con la memoria: l’eredità di una esperienza che senza pensarci troppo consegniamo al passato». Flige aveva sperato che in Russia si portasse a compimento un processo di de-comunistizzazione come in Germania si era proceduto alla de-nazificazione. Ma non era accaduto. Dopo trenta anni, il tempo della memoria non era ancora arrivato.
Negli anni Novanta erano già in fase di arresto i timidi tentativi di cominciare a costruire una memoria pubblica e condivisa a partire dalle ricerche per dare un nome, un luogo, una data di morte alle centinaia di migliaia di coloro che erano stati eliminati in modo anonimo negli anni del potere sovietico. I Russi erano più preoccupati di riuscire a mettere insieme il minimo per arrivare a fine mese che di sapere ciò che era accaduto ai loro genitori e nonni qualche decennio prima.
Meno di due anni dopo l’inaugurazione del monumento di Sandarmokh, era salito al potere Vladimir Putin, un ex colonnello del KGB, sull’onda di una campagna di propaganda basata sulla nostalgia e sulla rivendicazione di un immaginario passato sovietico eroico, felice e ordinato. Parlare del terrore staliniano diventò sempre più fuori moda e antipatriottico. I libri che riabilitavano Stalin ed anzi lo rivalutavano diventarono popolari. Le Memorial societies vennero prese di mira e additate come “agenti stranieri”. Venne bloccato e anzi invertito il processo di rimozione dei monumenti e delle statue e della toponomastica dell’era sovietica.

Fig. 4 Magadan, La maschera del dolore, monumento alle vittime del Gulag. By Сергей Ковалев – Own work, CC BY-SA 4.0, Link
Dal Cremlino venivano ora nuovi segnali, taciti o espliciti: la memoria del passato doveva essere riscritta; e in questa, Stalin doveva riassumere una nuova-vecchia dimensione: quella di un grande leader che aveva vinto la Seconda guerra mondiale e aveva reso la Russia grande e potente. Poteva anche aver esagerato, ma studiare e prendere di mira i suoi “eccessi” (così venivano chiamati) significava tornare all’epoca della glasnost, che aveva portato al collasso dell’Unione Sovietica, «la più grande catastrofe geopolitica del nostro tempo» secondo Putin.
Negli anni successivi cominciarono ed essere pubblicati dozzine di libri di storia revisionista e di narrativa di immaginazione, tutti orientati ad esaltare Stalin e i suoi sodali, come pure l’eroismo degli uomini della polizia segreta. Le librerie avevano interi scaffali dedicati e negli aeroporti erano quasi gli unici libri venduti.
Quale storia potrebbe e dovrebbe raccontare un museo statale russo?
Nel frattempo, erano stati allestiti molti musei sul terrore sovietico, fuori della Russia però: a Riga, a Berlino, a Varsavia, a Budapest. Ogni museo racconta una storia. Quello di Riga guida il visitatore attraverso una prigione sovietica; in quello di Varsavia viene ricordato il tradimento del 1944, quando le truppe sovietiche rimasero a guardare i nazisti che massacravano il popolo; a Berlino diversi musei documentano la vita spiata; a Budapest in una Casa del terrore si raccontano, una accanto all’altra, le storie dell’occupazione nazista e sovietica, opportunamente dimenticando di ricordare la collaborazione ungherese con la Germania nazista.
Queste storie hanno in comune il fatto che tutte raccontano la fondamentale innocenza e integrità della nazione di cui sono espressione, mentre la storia del terrore sovietico, che hanno subito, è la manifestazione del potere ostile di un Altro capace di terribili atrocità.
Ma, quale storia potrebbe e dovrebbe raccontare un museo statale russo? Per 70 anni i Russi, tramite gli apparati statali, hanno volto un potere illimitato e crudele contro sé stessi: il paese non era sotto occupazione, né la violenza fu esercitata contro una popolazione ritenuta diversa; i milioni che perirono nei Gulag non furono uccisi perché parte di minoranze etniche o religiose o perché omosessuali; la popolazione dei campi era la stessa popolazione del paese, e dunque Russi in maggioranza, ai quali fu a caso appioppata l’accusa di essere “nemici del popolo”.
I Russi, dunque, non hanno un Altro, un’altra nazione, un altro popolo cui incolpare sofferenze, torture. Né possono, come fanno alcuni Tedeschi per i loro dodici anni di Nazismo, parlare di un breve attacco di follia nazionale, perché il regime sovietico è durato sette decenni. I Russi non hanno neppure la possibilità di dividersi e di dividere i loro antenati nelle categorie nettamente distinte di vittime, persecutori, spettatori, come hanno fatto i Tedeschi: la maggior parte dei Russi sono stati persecutori e vittime ad un tempo, non ci furono semplici spettatori.
Ma, se la responsabilità e il biasimo per le atrocità dell’epoca sovietica non possono essere riversati su qualcun altro, un altro popolo, o anche su un gruppo ben individuato e ristretto di Russi, allora non resta che trasformare una storia di terrore in una storia gloriosa.
Ecco dunque attraverso quali vie si è arrivati a giustificare Stalin e a farne un eroe e un grande leader di cui rivendicare le conquiste, e ad assolvere, insieme con Stalin, il paese di cui fu guida per quasi trent’anni.
Perm-36, un Gulag restaurato
Le vie dell’oblio e della confusione delle responsabilità possono essere però anche più tortuose e sorprendenti, come dimostra la vicenda del Gulag di Perm. Masha Gessen la racconta in tre distinti brevi capitoli.
Negli Urali, distante alcune ore dalla città di Molotov (il nome le veniva dal ministro degli esteri di Stalin e il negoziatore del patto nazi-sovietico del 1939), nel 1946 venne creato un Gulag per la lavorazione del legname. La gran parte dei prigionieri non furono internati per reati “politici” ma per quelli che il regime considerava crimini economici: furto di proprietà statali, frode, appropriazione indebita. Le loro condanne non erano di lunga durata e infatti furono amnistiati dopo la morte di Stalin, nel 1953, mentre i “politici” dovettero aspettare ancora altri cinque anni.
Ancora negli anni Settanta però, sotto Brezhnev, il campo restava adibito a carcere per i dissidenti: attivisti dei diritti umani, indipendentisti delle varie repubbliche, sostenitori della libertà religiosa, scrittori underground, giornalisti. Per i “politici” recidivi, ritenuti dal potere particolarmente pericolosi, fu creata una Zona Speciale di confino nelle cui celle quasi non penetrava la luce naturale.
Intanto, il nome Molotov era stato cancellato e la città aveva ripreso il nome presovietico di Perm; anche al campo venne attribuito un altro nome, Perm-36.
Nel febbraio 1988 vennero amnistiati diverse centinaia di prigionieri politici e Perm-36, svuotato, venne abbandonato.
Nel 1992 gli storici Victor Shmyrov e la moglie Tatyana Kursina cominciarono ad occuparsi del restauro e della conservazione del campo, che consideravano uno degli ultimi rimasti relativamente integri dell’epoca staliniana. Furono loro necessari venti anni per restaurare tutte e dodici le strutture del campo: le baracche-dormitorio, le celle di isolamento, la segheria, le torri di guardia, le latrine esterne, l’infermeria.

Fig. 5-Perm-36,-Gulag-sovietico. Immagine tratta da Never Remember. Searching for Stalin’s Gulags in Putin’s Russia, Columbia Global Reports, New York 2018.
Ma già dal 2005, Shmyrov e Kursina organizzavano nel campo un festival per cantautori, genere popolare nell’underground sovietico, e perciò, così sembrava, abbastanza adatto al luogo. Il festival, cui venne dato il nome il nome “La Segheria”, diventò un evento annuale, un po’ convegno di ONG, un po’ raduno di ex prigionieri politici, un po’ concerto rock, un po’ curiosità, che arrivò ad attirare fino a 15.000 partecipanti, attendati nel circondario nei prati e tra gli alberi della foresta.
Ma un crescente numero visitatori vedeva Perm-36 come una meta di pellegrinaggio ad un sito nel quale si era manifestata la potenza e la grandezza di Stalin e del potere sovietico. Arrivavano perciò al campo indossando le divise della polizia segreta staliniana (a Mosca era sorto un negozio specializzato in ordini di quel genere) e inalberando i ritratti di Lavrentiy Beria l’ultimo e più noto capo della polizia segreta.
Nel 2011 il governatore della regione propose di trasformare Perm-36 in un museo e Shmirnov e Kursina, anche se il loro obbiettivo era solo quello di conservare la struttura, presero contatti con uno studio americano di design al fine di creare un percorso museale interattivo.
Perm-36: un museo ufficiale del Gulag
Ma nel 2012, dopo il temporaneo passaggio al potere di Dmitry Medvedev, Putin era tornato alla presidenza, dando inizio ad un nuovo giro di vite politico. Il governatore di Perm perse la carica e fu costretto a lasciare il paese. Nel 2013 le autorità posero fine al festival di Perm-36 e si impadronirono del campo e delle sue restaurate strutture, nonostante i disperati tentativi di Shmyrnov e Kursina di mantenerne il controllo, dopo un lavoro durato oltre vent’anni.
Ma il campo di Perm-36 era ormai avviato a diventare un museo del Gulag, paradossalmente votato alla riabilitazione, seppure per vie tortuose inattendibili, del potere dispotico che lo aveva creato.
Masha Gessen visitò il campo nell’aprile 2016, accompagnata dalla guida, una trentenne ex insegnante del villaggio, che spiegava con lo stesso tono ufficiale delle guide di tutti i musei che Masha aveva visitato quand’era bambina. «Qui potete vedere le tipiche baracche del campo; e qui è stato prigioniero Sergei Adamovich Kovaliov, un illustre studioso di genetica». La guida sembrava fiera del “soggiorno” di una celebrità in quello che, dopo tutto, era stato un Gulag, un luogo di pena e di afflizione.
Kovaliov vi era stato infatti richiuso per cinque anni dal 1975, quando aveva 45 anni, anziano per gli standard dei campi sovietici e innocuo a detta dei guardiani. In realtà, le sue “attività antisovietiche” avevano avuto inizio già negli anni Cinquanta, quando, giovane ricercatore di biologia, si era impegnato in una difesa della genetica, scienza proibita in Unione Sovietica. Nel 1969 aveva contribuito a fondare la prima organizzazione per i diritti umani e nel 1971 una rivista clandestina di documentazione delle violazioni di tali diritti. Arrestato nel 1974, aveva subito una condanna a sette anni di campo – Perm-36 appunto – e tre di esilio interno. Al campo, per una infinità di volte, fu rinchiuso in una cella di isolamento dove si riceveva da mangiare ogni due giorni, – ciò che significava essere tormentati in continuazione dai terribili morsi della fame –, si dormiva, al freddo, su un tavolaccio senza pagliericcio e si disponeva solo di biancheria intima e ciabatte.
Ora, la guida di Perm-36 sembrava orgogliosa che in quel campo avesse trascorso anni di prigionia un personaggio come Kovaliov. Come era fiera di sottolineare l’efficienza sovietica della struttura dalla quale era stato impossibile evadere. Sembrava proprio orgogliosa di qualsiasi cosa avesse funzionato come doveva, senza scrupoli etici e senza neppure porsi l’ombra di un dubbio circa il bene che era stato sottratto e il male che era stato inferto.
Continuando la vista, la guida fu particolarmente lieta di condurli in una stanza intitolata “L’evoluzione del letto”, dove veniva mostrato il progresso dalle panche a due livelli a quelle ad un livello solo, alla vera e propria branda con spalliere in testa e ai piedi. Con il passare degli anni, i prigionieri dormivano sempre meglio; questa la lezione della mostra e della guida.

Fig 6 Magadan, resti-di-un-Gulag. Immagine tratta da Never Remember. Searching for Stalin’s Gulags in Putin’s Russia, Columbia Global Reports, New York 2018.
D’altra parte Gessen conosceva già questo modo di presentare l’esperienza del Gulag e della prigionia; in occasione del processo a Mosca di un artista, accusato di aver danneggiato i locali del quartiere generale del KGB, aveva sentito un esperto testimoniare che gli edifici del KGB erano di “rilevanza culturale” perché molti grandi artisti e scrittori erano stati rinchiusi nelle loro celle. «Un nuovo modo di mettere insieme vittime e carnefici – commenta Gessen – dove lo Stato rivendica meriti per il talento e le conquiste delle sue vittime; come se, privandole della libertà, torturandole, uccidendole, ne avesse ereditato e incorporato tutti i loro pregi».
Come non ricordare: del buon uso di Shalamov
Ma la mistificazione di Perm-36 trovava una paradossale e grottesca evidenza in una citazione di Varlam Shalamov, lo scrittore che aveva trascorso più di 15 anni nei Gulag, due a Perm appunto e gli altri a Kolyma: «L’uomo è felice se è capace di dimenticare. La memoria e sempre pronta a dimenticare il male per ricordare unicamente il bene». Insomma, quella citazione, isolata, sembrava un invito a dimenticare da parte di uno che aveva sperimentato sulla propria pelle le spaventose condizioni di vita prossime alla morte nel gelo delle miniere della Kolyma.
Ma si trattava appunto dell’uso distorto e truffaldino di una frase espunta dal contesto di uno dei racconti di Shalamov “A razione secca” che qui si riporta dall’edizione Einaudi dei Racconti di Kolyma:
L’amicizia non nasce nel bisogno e nella disgrazia. Quelle famose condizioni di vita «difficili» che secondo le favole della letteratura costituiscono la base necessaria perché l’amicizia si sviluppi, evidentemente non sono poi così difficili. Perché se la disgrazia e il bisogno hanno potuto rafforzare o suscitare l’amicizia tra le persone, significa che non si trattava di un bisogno estremo né di una grande disgrazia. Il dolore non è abbastanza acuto e profondo se lo si può ancora condividere con gli amici. Nel momento del vero bisogno si conosce soltanto la propria personale forza fisica e fermezza spirituale, si definiscono i limiti delle proprie risorse, della resistenza fisica e della forza morale.
Tutti noi ci rendevamo conto che se fossimo sopravvissuti sarebbe stato per puro caso. Fatto strano, un tempo, da giovane, c’era un’espressione che mi ripetevo ad ogni insuccesso o difficoltà; «Di fame non moriremo comunque». E credevo, credevo con ogni fibra del mio essere in questa frase. Ed ecco che a trent’anni mi ritrovavo nella situazione di un uomo che muore veramente di fame, che lotta letteralmente per un tozzo di pane, e questo accadeva molto prima della guerra.
Quando noi quattro ci eravamo ritrovati al Duskan’ja sapevamo che non per amicizia eravamo lì, e sapevamo anche che se fossimo sopravvissuti, ci saremmo rivisti malvolentieri. Sarebbe stato sgradevole ricordare tante cose brutte: la fame che ci faceva quasi impazzire, la disinfestazione dei pidocchi nei barattoli dove si cucinava, le incontenibili fandonie attorno al fuoco – fandonie-desideri – le fantasie gastronomiche, le baruffe e i nostri sogni tutti uguali, perché facevamo tutti sempre lo stesso sogno; pagnotte di pane di segala che ci sfrecciavano accanto come bolidi o angeli.
L’uomo è felice se è capace di dimenticare. La memoria è sempre pronta a dimenticare il male per ricordare unicamente il bene. Non c’era niente di buono sul Duskan’ja e neppure sul cammino che ognuno di noi si era lasciato alle spalle, né in quello che lo attendeva, che attendeva tutti noi. Il Nord ci aveva avvelenati per sempre e noi ne eravamo consapevoli. Tre di noi avevano smesso di opporsi alla loro sorte, e il solo Ivan Ivanovic continuava a lavorare con lo stesso tragico zelo di prima.
(Varlam Shalamov, I racconti di Kolyma, Volume primo, Einaudi, Torino 1999, pp. 52-53).
Ma come è possibile comprendere l’esperienza del Gulag sovietico quando la storia raccontata ti dice che grandi personaggi vi hanno trascorso anni della loro esistenza, che le condizioni erano brutte ma che sono migliorate, che era una prova di efficienza non lasciar evadere i prigionieri e che dimenticare è una bella cosa? Una cacofonia e una confusione che crea un senso di neutralità morale.
Insomma, questo è il senso del libro Never remember, in Russia il tempo della memoria non è mai veramente arrivato.



















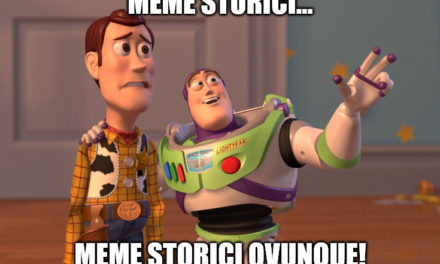



 Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini
Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Cassandra a Mogadiscio
Cassandra a Mogadiscio Identità di confine. Storia dell’Istria e degli istriani dal 1943 a oggi
Identità di confine. Storia dell’Istria e degli istriani dal 1943 a oggi Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini