
Trent’anni di storia che si possono insegnare
Abstract
La storia italiana degli ultimi trent’anni si inserisce in un’epoca storica, quella della globalizzazione, che l’analisi storiografica è già in grado di periodizzare. È dunque anche “insegnabile” a scuola, a patto di allontanarsi dalle vicende politiche nazionali quel tanto che basta a vedere l’Italia inserita nel più vasto contesto europeo e internazionale.
-
Alcune questioni di metodo
Gli ultimi trent’anni: un’epoca storica?
Parlare degli ultimi trent’anni della storia d’Italia rischia di essere un terreno molto scivoloso. Noi tutti crediamo di saperla, questa storia, avendola vissuta. Invece non la conosciamo, perché il passato, per essere conosciuto, ha bisogno di essere ri-elaborato storiograficamente. Per poterlo studiare è necessario fare le classiche operazioni dello storico. La prima domanda da porsi è se gli ultimi trent’anni della storia d’Italia siano un’epoca storica o, invece, una sorta di lungo “processo di transizione”. Abbiamo, cioè, vissuto gli ultimi trent’anni dentro una transizione che non finisce mai, che aveva il suo punto di partenza nella repubblica dei partiti (semplifico), e che avrebbe dovuto portarci verso una nuova epoca della storia d’Italia? Se la risposta è sì, sarebbe difficile studiare questo periodo: le transizioni non si possono studiare quando ci si vive dentro. Ciò che si può studiare è il loro esito. Io però non sono convinto che sia così. Sono convinto che gli ultimi trent’anni siano un’epoca storica e cercherò, nel corso di questi nostri lavori, di dimostrarvelo.
Tre contesti: il contesto internazionale
Trent’anni sono molto lunghi: sono più lunghi del fascismo, dell’Italia giolittiana, della destra storica; sono lunghi più di un intervallo generazionale. E questi ultimi trent’anni sono, a mio avviso, un’epoca storica, e non solo per l’Italia. Ovviamente, come per ogni epoca storica, noi dobbiamo individuare gli elementi costitutivi che la differenziano dalle epoche precedenti e, quando gli storici del futuro la studieranno, dalle epoche storiche successive. Per far questo dobbiamo guardare innanzitutto alla dimensione internazionale. Poiché sono convinto che la storia del XX secolo – ma già anche la storia degli ultimi cinquant’anni dell’Ottocento – non si può affrontare senza una dimensione internazionale (per il livello di interconnessioni planetarie che dall’economia si sono progressivamente spostate alla comunicazione, alla tecnologia, all’arte, alla cultura, insomma a tutti i paradigmi globali e mondiali che costituiscono, a mio avviso, l’essenza del Novecento), per prima cosa va ricercato il contesto mondiale in cui la storia d’Italia si inserisce. E questo contesto è, ovviamente, la globalizzazione, che è una forma specifica di mondializzazione.
Il contesto europeo
La globalizzazione non è l’unica forma di mondializzazione che noi conosciamo, è una forma diversa. La mondializzazione c’era già da fine Ottocento: a fine Novecento il mondo era “mondiale” già da un secolo. Noi dobbiamo individuare altri fenomeni. Innanzitutto guardare a quel un contenitore subglobale che è l’Europa, perché in questi trent’anni l’Europa non è più l’Europa dei trent’anni precedenti, l’Europa del Mec. Ora l’Europa non è più solo l’Europa della moneta unica, ma è un’Europa che cerca di diventare una forza integrante e integrata. L’Italia non si può studiare se non dentro questo contenitore, anche perché uno degli aspetti caratteristici dello stato della globalizzazione contemporanea, cioè della mondializzazione odierna, è che, a differenza delle mondializzazioni del passato, questa globalizzazione mette in discussione elementi centrali della sovranità dello stato nazionale. Quindi, da questo punto di vista, si tratta di una novità che riguarda anche l’Italia, la sovranità dello stato italiano. L’Italia va dunque studiata come parte di quel mondo integrato che noi chiamiamo “mondo globale”. E dobbiamo guardarvi come a una parte costituente, anzi, come a una parte costitutiva, visto che è stata fra i fondatori dell’Unione europea.
Il contesto italiano
Ma ci sono altri elementi che caratterizzano la storia di questi trent’anni e che vedono l’Italia come paese anticipatore dei processi che si realizzeranno in altri paesi: la fine dei grandi partiti di massa; la nascita di forme originali di populismo; la riscoperta di dimensioni ideologiche di stampo neoliberale; l’integrazione tra processi di trasformazione della massificazione della società e l’emersione di forme del tutto originali di individualismo (scusate l’ossimoro) “collettivo”, che si riverberano sulla politica, sul modo di concepire il rapporto tra gli individui e la società; la trasformazione della “democrazia delle masse” dell’immediato dopoguerra in quella che Diamanti ha chiamato la “democrazia del pubblico”. Bene, tutti questi processi individuabili nel caso italiano, sono processi che riguardano tutti i paesi dell’Occidente, seppure in forme diverse. Pensate a Trump. La sua elezione non fa che dimostrare (cosa che ho sempre ho sempre pensato) che Berlusconi non fosse un’eccezione, ma fosse un processo del tutto simpatetico e significativo del cambiamento della democrazia e della società globale.
Ovviamente tutto questo va studiato. Vanno analizzati i paradigmi: dimensioni strutturali, dimensioni ideologiche, dimensioni che connettono nazionale e internazionale, perché l’Italia non solo sta dentro la globalizzazione, ma ci sta da potenza media. Non detta la storia – non l’ha mai dettata – ma non è neppure il “brutto anatroccolo”; sta nell’orchestra, e quando l’orchestra cambia musica, deve cantare la canzone che cantano tutti gli altri. Vanno dunque ricercati i caratteri di quest’epoca. I caratteri omogenei, omologhi, dentro cui possiamo inserire le differenze locali, in questo caso nazionali: i processi di trasformazione economica e culturale; gli strumenti delle tecnologie; le comunicazioni di massa e così via.
Quando iniziò l’ultimo periodo della storia italiana
Dopo di che, come per tutte le epoche, quest’epoca storica va periodizzata. E in questo siamo fortunati, perché siamo arrivati ad un grande showdown mondiale: la quarta crisi generale del capitalismo. Ora, le crisi del capitalismo, come ci hanno insegnato gli storici, gli economisti, i sociologi, segnano la fine delle epoche, impongono cambiamenti profondi. Come ha detto Gurrieri “cambiano la faccia delle nazioni”. Possiamo già ora guardare a quest’epoca sapendo che si è prodotta una cesura. A partire dal 2008, il mondo in cui noi stiamo vivendo e che storicizzeremo a partire da altri parametri, è un mondo diverso, anche se non sembra, dal mondo del decennio precedente. Inoltre, siamo ancor più fortunati (come storici, ovviamente) perché dentro questa cesura in Italia cascano anche tutti gli attori che avevano avuto un ruolo centrale nella storia del ventennio, trentennio precedente: cade Berlusconi, cade la Lega, cade l’etnopopulismo che aveva guidato il paese per un decennio. Quindi c’è una cesura in più. L’internazionale si combina con una cesura locale, che investe non solo l’economia, ma la politica. E, se dal punto di vista economico la crisi italiana è uguale alla crisi di tutti gli altri paesi, ad essa l’Italia aggiunge la caduta dei parametri politici ideali che si erano imposti nel decennio precedente.
L’assassinio di Aldo Moro
Se, dunque, è semplice trovare il termine ad quem, e cioè la conclusione di quel trentennio di cui abbiamo parlato, va ora ricercato il termine a quo. Ma per stabilire quando comincia questo trentennio, dobbiamo prima stabilire se si tratta davvero di un trentennio o non, piuttosto, di un ventennio. Perché noi abbiamo una “datona” nella storia d’Italia, che è anche una data fondamentale della storia europea, cioè il 1991-92. “Tangentopoli” e la caduta della repubblica, di fatto travolta dal debito pubblico, coincidono con le trasformazioni della comunità europea seguite all’89. E questa caduta risente di questo processo di cambiamento, ovvero del più grande slancio globalizzante della politica economica finanziaria dell’Europa, che detta le regole di cui ancora adesso si parla. Il trentennio in questo caso si ridurrebbe a un ventennio. Io però non sono convinto di questo, e non solo perché non ho una visione criminale della storia d’Italia.

Di sconosciuto – http://www.iljournal.it/2012/dal-sequestro-alla-morte-una-gallery-per-moro/323039%20/via-fani2, Pubblico dominio, Collegamento
Tangentopoli è una cosa circoscritta, che secondo me spiega poco della storia d’Italia. A mio giudizio, e poi cercherò di dimostrarvelo, gli anni Ottanta sono già l’incubatore della crisi politica. Dentro gli anni Ottanta sono già iscritti i processi e le dinamiche che porteranno a quella crisi. Quindi quella crisi non è un inizio, ma è una fine che obbliga ad un cambiamento. Una fine che era cominciata dieci anni prima, perché io sono convinto che la “prima repubblica” sia morta in via Fani: sono convinto che fu il delitto Moro a sancire la fine della repubblica dei partiti. Non è un caso che intorno a quegli anni si cominci a discutere di riforme delle istituzioni, di cambiamenti dei partiti, di processi di trasformazione delle culture politiche italiane, che porteranno poi a quell’esito. Certo quell’esito, cioè il 1992-93, è legato a dei fattori internazionali (fallimento del comunismo, crollo di una prospettiva di alternativa globale al capitalismo di mercato e alla democrazia), ma non è il punto di partenza. È chiaro che le date non collimano per intero, però non c’è dubbio, almeno a mio modestissimo avviso, che la data di partenza di questo trentennio è quel 1979-80 in cui succedono, per lo meno nella storia d’Italia, due fatti decisivi: uno – l’abbiamo già citato – è la morte di Moro; l’altro è la “marcia dei 40.000”, che – di fatto – fa finire il sindacato. Nel 1979 nascono peraltro, se non ricordo male, le televisioni private.
Posti questi paletti, siamo ora pronti ad analizzare e a raccontare questo trentennio, sapendo però che, una volta decisa questa periodizzazione e l’approccio metodologico che mette insieme nazionale e internazionale, alcuni dei fatti ritenuti fondamentali verranno scartati, mentre ne emergeranno altri che sono sfuggiti alla memoria e all’immagine collettiva: rilevanze che potrebbero avere una assoluta discrasia rispetto alla memoria che ciascuno di noi ha dei fatti di cui ci occuperemo.
Le basi sociali della storia italiana
È bene che chiarisca la mia ipotesi storiografica, il mio modo di leggere il passato e di fare lo storico. Io non sono mai stato uno storico politico, perché la storia politica sostanzialmente mi annoia. Mi sono sempre occupato di storia sociale, di storia economica, di storia dei movimenti. Nel confronto con la storia politica del trentennio di cui stiamo parlando, ho cercato di arrivare a spiegare anche i processi politici a partire da un quadro interpretativo che muove da altri punti di vista, che chiamerei socioeconomici e, anche, per molti aspetti, culturali. La politica, per me, sta dentro questi quadri interpretativi. So che in questo mio modo di procedere la politica perde un po’ di autonomia e tutta la rilevanza che le attribuiamo in base al fatto che è quella parte della storia che, tutto sommato, noi vediamo e viviamo come individui. Nessuno di noi “vive” una crisi demografica: la si scopre quando è successa. Invece la politica ha una sua emergenza. Non voglio tornare alla tripartizione dei tempi della storia che aveva fatto Braudel, ma il fatto che la storia politica stia “sopra”, sia ciò che è immediatamente riconoscibile nei processi storici, non deve fare dimenticare non tanto il fatto che la politica sia, marxianamente, una conseguenza dei processi strutturali, ma il fatto che sono i processi strutturali sociali profondi delle società a modellare e rendere comprensibili anche i fatti politici. O, meglio, rendono comprensibile il movimento storico, che riguarda anche la politica. E il movimento storico è quello che a me personalmente poi interessa.
-
Una sintesi dell’ultimo trentennio di storia italiana
I “trenta gloriosi”
Allora da dove partiamo? Partiamo da un elemento che può apparire lontano dal nostro ragionamento, ma che secondo me è profondamente vicino, perché l’eredità di quei processi è ancora profondamente operante nella memoria dei viventi. Vorrei partire dal miracolo economico, o, meglio, da ciò che resta di quel trentennio di sviluppo dell’economia che la storiografia ha definito “i trenta gloriosi”. Cosa resta? Restano indubbiamente un balzo della crescita straordinaria, la diffusione e l’affermazione di un’economia industriale, ma, rispetto a quello che era accaduto tra le due guerre mondiali, restano anche altri processi di straordinario interesse, quali la fine del colonialismo e una nuova dislocazione delle forze tra il centro e le periferie del mondo. In quei trent’anni cambia complessivamente il pianeta e questo cambiamento coinvolge, travolge potremmo dire, il mondo. E l’Italia sta nel mondo, non è che sia in un altro posto. Sta lì.
Ovviamente, l’Italia non è stata toccata da alcuni problemi legati alle transizioni coloniali. Per noi quelle si sono risolte subito, nel ’45. Non abbiamo dovuto fare guerre d’Algeria, o operazioni complicate come quelle che hanno dovuto fare altri paesi, nel ’56: la crisi con l’Egitto, lo stretto di Suez. Noi siamo fuori da questo universo. Ma noi siamo comunque dentro questo mondo. E cosa significa stare dentro questo mondo se lo guardiamo dalla prospettiva dell’Occidente? Significa che le forze che hanno pilotato la vittoria contro il nazifascismo hanno ricostruito l’Europa su tre fondamentali paradigmi, tre fondamentali pilastri, riconoscibili già dal 1943-46.
Primo pilastro: il riconoscimento di un’egemonia mondiale
Dopo la crisi dell’egemonia britannica, che aveva attraversato la prima metà del secolo ed era stata sicuramente una delle grandi cause della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale finisce con una ritrovata egemonia. Questa egemonia si rompe, tra il 1947 e il 1948, in due, dando luogo alla guerra fredda e alla divisione delle aree del mondo. Per quanto riguarda l’Occidente, però – il mondo del cosiddetto capitalismo di mercato – c’è una sola forza egemone: c’è chi detta le regole del gioco, chi detta la tabella di marcia, chi detta gli strumenti con cui gli stati seguono la nuova dinamica economica. C’è una forza egemone, dunque, e questa forza egemone (scusate se uso un aggettivo che può sembrare decontestualizzato) è una forza antifascista. Dall’antifascismo militante, dalle lotte degli anni ’30, la forza egemone recepisce infatti gli altri due pilastri su cui si fonda lo sviluppo: libertà di mercato e welfare state.
Il secondo pilastro e il terzo pilastro: la Libertà di mercato e il welfare
È subito chiaro che bisogna abbandonare il protezionismo, che, con le sue derive autarchiche, era stato la grande causa della seconda guerra mondiale e bisogna tornare al capitalismo libero, al libero mercato. Un libero mercato governato da stati, però, che mantengono il controllo della finanza e della moneta, in un quadro di ritorno a politiche di base aurea monetaria, agli scambi fissi tra le monete (che dureranno fino agli anni settanta.
Per welfare si intende non solo Beveridge, ma quell’insieme di politiche di sostegno alla domanda e di sostegno al benessere, che caratterizzeranno le politiche economiche di tutti i paesi industrializzati dell’Occidente, Italia compresa. Su questi tre pilastri: antifascismo – e quindi ricostruzione della democrazia dentro i paradigmi dell’antifascismo, ovvero con partiti e parlamentarismo – combinato al welfare e combinato a un capitalismo libero, ma dove lo stato assume una regolazione di fondo di quel nodo cruciale che è la moneta, si ricostruisce l’Europa. Questo sistema, che da molti sociologi è stato definito di “universalismo progressista”, è quello che tiene insieme le democrazie dell’Occidente per trent’anni. Tutte le democrazie, anche quella italiana – dove è vero che c’erano i comunisti, Scelba, la Celere, i moti contadini, gli anni Sessanta – ma dove dietro a tutto questo c’era un grande strumento di coesione determinato dal compromesso antifascista.
È inutile chiedersi se l’antifascismo abbia davvero vinto o no. Ha vinto “al cubo”. Certo, non ha vinto come volevano i resistenti. Non c’è stata l’unità antifascista. Ma ha vinto molto di più di così, perché ha costruito le fondamenta su cui si è retto l’Occidente e che hanno determinato quel processo di sviluppo dentro cui si è collocato il più grande traguardo di uguaglianza nel benessere. Ecco perché tutti rimpiangono quel periodo.
Il paradigma antifascista
Il welfare negli anni cinquanta-sessanta era oggetto di contesa, di rifiuto, di dibattito. Marcuse temeva che il welfare integrasse la classe operaia, la omogeneizzasse, la omologasse. E il suo discorso si accompagnava a conflitti ideali e a grandi prospettive, che avevano in parte anche un loro fondamento. Se però lo guardiamo dal nostro osservatorio, il welfare ha modellato l’unica fase della storia del ventesimo secolo in cui le disuguaglianze si sono ridotte. Si erano ridotte anche un po’ all’inizio del Novecento. Un po’ di riformismo c’era stato anche allora: ma nulla a che vedere col welfare del secondo dopoguerra. E non solo si sono ridotte le disuguaglianze, ma come fondante delle società democratiche del dopoguerra – qui sta la discontinuità col prima – vengono assunti il lavoro, la classe operaia, i diritti civili, i diritti sociali.
I paradigmi dentro cui si costruisce questo comportamento politico sono quelli di Keynes. Keynes è la democrazia dei parlamenti, la democrazia delle assemblee legislative, la democrazia del welfare. E’ la democrazia dei diritti sociali e la democrazia delle negoziazioni tra sindacati e imprese, come soggetti legittimati alla conflittualità e al dialogo sociale.
Questo è il modello che ci consente di capire quel periodo. Poi c’è anche la politica, Scelba che ha ammazzato gli operai, gli scontri in Italia e in Germania, la questione razziale negli Stati Uniti. Tutto verissimo. Ma non dimentichiamo che tutte queste cose stanno dentro il quadro di cui si è detto, e questo spiega perché comunisti e democristiani e liberali vanno d’accordo: perché non c’è nessuno che rompe questo patto riformista e antifascista, neanche nei momenti di massima frizione della storia italiana.
E questo tessuto, questo patto è dentro la nostra Costituzione: per questo la Costituzione è antifascista. È costruita così.
Il ruolo dei partiti
Ovviamente un ruolo fondante nella democrazia keynesiana è rappresentato dai partiti. Non è ipotizzabile questo compromesso progressista e democratico in assenza dei partiti. Questo attore fondamentale è il fondamento della democrazia. Nelle democrazie di inizio ‘900 il partito contava poco. Nelle situazioni totalitarie il partito era uno. Mentre nel secondo dopoguerra il multipartitismo diventa il vero fondamento della democrazia, vale a dire del rapporto fra cittadini e istituzioni pubbliche.
Il partito significa pedagogia di massa, significa depotenziamento degli antagonismi irresolubili, significa che, in un universo pieno di rivoluzionari, ciò che muore è la rivoluzione. Quest’idea aveva animato la prima metà del Novecento e stava in campo come alternativa sistemica. La rivoluzione aveva nel marxismo la sua grande tradizione. Ma anche nell’universo fascista aveva trovato una sua declinazione, e sia Mussolini che Hitler erano convinti di essere rivoluzionari. Nel secondo dopoguerra invece, cioè nel momento in cui il compromesso funziona, il benessere, la partecipazione diventano progressivamente alternativi all’antagonismo sociale.
Stare nella democrazia significa accettare il fatto che l’idea di rivoluzione, elaborata nell’Ottocento e poi nel Novecento, vada nel dimenticatoio
Gli enti pubblici
Queste dinamiche sono state ovviamente diverse nei vari stati. In Italia, per esempio, avevamo un grande retaggio del fascismo: ereditiamo il grande sistema degli enti pubblici, come l’IRI. E lo incrementiamo addirittura, perché l’ENI l’ha inventato Mattei, non era un’eredità del fascismo. E questo significa già un rapporto tra stato, politica ed economia che si complica. La relazione tra la politica e l’economia, mediata dagli enti pubblici, vede la presenza di elementi corruttivi e di intermediazione clientelare tra i partiti e tutta questa baracca, ma fino a che c’è l’onda che alza tutte le barche – come diceva Kennedy – questi elementi sono ridotti, anche perché fortuna volle che avessimo un ceto di tecnici e di tecnocrati dello stato – molti dei quali avevano fatto grandi esperienze sotto il fascismo – di prim’ordine. Mattei, Beneduce, Sinigaglia, sono uomini che hanno in testa l’interesse dell’Italia, non quello dei loro partiti.
Il dualismo economico
Un’altra eredità fondamentale è un paese dualista. Pochi paesi d’Europa hanno un dualismo così accentuato. Allora è chiaro che le politiche a favore del Mezzogiorno, la Cassa del mezzogiorno, le grandi tradizioni di intervento dello stato attraverso gli enti pubblici determinano processi molto complessi e un rapporto tra istituzioni, cittadini e stato non impermeabile a fenomeni di clientelismo e corruzione. In questi primi anni, l’onda che alza le barche li rende meno visibili, ma ci sono; in un meccanismo che – come ha messo in evidenza l’economista Barca in un suo bellissimo libro – vede uno stato che interviene, ma non regola. Cosa che non accade in altri paesi, dove lo stato interviene molto meno, ma regola. Il fatto che noi nel 1990 non avessimo una legge antitrust “contro” Berlusconi, per impedire quello che in altri paesi era automatico, che in America c’era dalla fine dell’Ottocento, denota questa caratteristica: un capitalismo appoggiato da uno stato fortemente interventista, ma molto parco nel definire regole di funzionamento del mercato.
L’Italia sta dentro questo involucro internazionale con le sue specificità, le sue contraddizioni, i suoi limiti. Con una classe dirigente che, al di là del conflitto, non lacera quel compromesso non scritto, ma fondato sulla Resistenza. E tutto questo meccanismo fa una grande Italia. L’Italia diventa la sesta potenza industriale del mondo, compete con la Gran Bretagna per diventare la quinta. I livelli di reddito degli italiani crescono moltissimo: da paese povero diventiamo un paese ricco, da paese agricolo diventiamo paese industriale, da paese analfabeta diventiamo un paese alfabetizzato, da un paese immobile diventiamo un paese mobilissimo. Quindi l’Italia conosce una trasformazione radicale e velocissima, quale nessun altro paese d’Europa ha conosciuto. E, come sempre quando le cose sono troppo veloci, qualche cosa che non va succede.
La crisi degli anni Settanta
Tutta questa dinamica si è scassata, inevitabilmente e drammaticamente, negli anni Settanta. Questo sconquasso è l’inizio del nostro ragionamento, perché noi dobbiamo ipotizzare che questi trent’anni sono compresi tra due crisi: quella degli anni Settanta e quella del 2007-2011. Questi trent’anni stanno dentro queste crisi e ci stanno da due punti di vista: come cambiamento delle strutture e come spazio storico di costruzione di un modello storico, civile ed economico profondamente diverso da quello precedente e che vi ho rapidamente descritto.
Negli anni ’70 gli shock petroliferi, il crollo della moneta, la fine dell’accordo di Bretton Woods seguito alla dichiarazione di non convertibilità del dollaro dichiarato dagli Stati Uniti nel 1971, determinano la fine del sistema finanziario internazionale dell’immediato dopoguerra. Nel frattempo però l’apparato produttivo italiano si è messo in moto. L’Italia non affronta la crisi come negli anni Trenta, quando era un paese di contadini. La affronta come paese industriale, con strumenti di politica economica e istituzioni democratiche. Però la affronta in un contesto nel quale i suoi punti di forza cominciano a diventare dei punti di debolezza.
Diventa un punto di debolezza una enorme industria pubblica sempre meno produttiva e sempre più legata alla politica, senza la quale quelle aziende non avrebbero potuto essere rifinanziate, non avrebbero potuto resistere alla pressione della crisi. Un altro punto di debolezza è la difficoltà dei partiti di ricostruire le condizioni di una nuova pattuizione come quella del ‘45. Non ci riescono. Non riescono a venire a capo di questa crisi, anche perché, più questa si aggrava, più la Democrazia Cristiana diventa partito- stato e più il Partito Comunista diventa un partito “pigliatutto”, cioè un partito che deve occuparsi non più soltanto dei propri referenti storici, ma di classi medie, piccola borghesia, ceto medio, operai: universi sociali diversi da quelli delle origini.
Infine gli strumenti messi in campo per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno cominciano a diventare pesantissimi strumenti di riproduzione di cosche clientelari. Non solo politiche, perché sono cosche che non vanno più a finanziare il sistema industriale e le politiche di sviluppo, ma i redditi. Quando in Calabria ci sono 25.000 forestali, quando nel Mezzogiorno ci sono 50.000 falsi invalidi, capite bene come significa riorientare il welfare dalle imprese agli enti. Poi ci sono anche la clientela politica e la ruberia che ben conosciamo, ma al fondo c’è un riorientamento progressivo di quegli strumenti verso operazioni di sostegno ai redditi. Perché quando la crisi si manifesta, non c’è più il ciclo economico che tiene sue tutte le barche e va a rotoli anche il welfare. Questo, come tutti i diritti sociali, non è un diritto sganciato da una sua base economica. Il diritto di parola, come il diritto di voto, non ha costi. Il diritto alla pensione invece sì.
Come si può sostenere quel meccanismo di diritti senza lo sviluppo? Per navigare nelle acque procellose della crisi rimangono due strumenti fondamentali di navigazione.
Svalutazione della lira e costruzione del Welfare
Il lungo cammino italiano nella crisi è legato ai due strumenti di cui vi volevo parlare. Il primo – utilizzato per tutti gli anni Settanta e gli anni Ottanta – è stato la svalutazione della lira. Liberata dagli accordi di Bretton Woods, la lira diventa, come negli anni Trenta, un grande strumento di politica economica. Io svaluto e quindi consento alle merci del nostro paese di stare nella concorrenza.
La leva della cosiddetta svalutazione competitiva sarà la grande arma che utilizzeranno i governi negli anni Settanta. Negli anni Ottanta, la cosa diventa però più difficile, perché, fra le tante cose che succedono nel famosissimo 1979, c’è anche l’entrata in vigore del serpentone monetario. Su quello cadrà il governo di unità nazionale, perché i comunisti non vogliono far entrare la lira dentro nel serpentone, ovvero privare il governo dello strumento della svalutazione competitiva.
L’Italia affronta la crisi con un grandissimo sforzo per portare a termine il welfare. Non dobbiamo dimenticare che i governi di “solidarietà nazionale”, presieduti da Andreotti, fanno la riforma del sistema sanitario (quello che introduce il welfare universalistico, 1978), fanno una legge 180 sulla riforma del trattamento psichiatrico, e una serie di altri provvedimenti: il più grande sforzo riformista che viene promosso nel contesto dato, utilizzando la leva della svalutazione pro gressiva. Si cerca, cioè, di uscire dalla crisi senza perdere i vantaggi del trentennio precedente.
Quindi i governi di solidarietà nazionale – tutti ricordano il dibattito, Moro, il compromesso storico, Berlinguer – sono l’ultimo tentativo di tenere insieme i Trenta gloriosi in un contesto in cui il mondo precipita in una crisi che non è in grado di governare. Quando poi, nel ’79, c’è il secondo shock petrolifero, che aggrava in maniera pesantissima la dinamica della crisi, tutti gettano la spugna: la gettano i governi di unità nazionale, la getta Carter, la getta il riformismo dello PSOE in Spagna, la getta perfino Mitterand, che dice ai comunisti di togliersi di torno e fa un altro governo, e comincia a entrare in crisi proprio in questi stessi anni il grande esperimento del riformismo socialdemocratico dell’Europa settentrionale.
Non dimentichiamoci che Palme, il primo ministro svedese, viene ucciso nel 1982.
Due partiti che non si sanno trasformare
Questo è il processo in cui l’Italia è inserita. In questo contesto, in cui sono riconoscibili dei tratti comuni, l’Italia fa questo tentativo, che non riesce come si sarebbe voluto, perché gli strumenti per farlo sono poco adeguati. I partiti non hanno saputo, potuto, voluto, mettere in campo quel processo di trasformazione profondissima che avrebbe obbligato i più grandi partiti del quadro nazionale, e cioè il Partito comunista e la Democrazia cristiana, a un cambiamento radicale.
Moro lo disse che la Democrazia cristiana doveva cambiare radicalmente di fronte al terrorismo, di fronte alla crisi del ’77 – una fase cupissima della vita nazionale -, di fronte a un’inflazione che cresceva a due cifre.
Capisce che c’è un problema di crisi di sistema. E lo capisce anche Berlinguer che c’è una crisi di sistema. E che soltanto quelle due forze – che messe insieme facevano il 75% della base elettorale – avrebbero potuto avviare un cambiamento. Tentano coi governi di unità nazionale, però le loro culture si dimostrano inadeguate per questo processo. La Dc non vuole perdere la sua natura di partito-stato, e quindi di controllore dell’intermediazione politica degli interessi che era la sua forza, non solo nel Mezzogiorno, ma anche nel resto dell’Italia; e il Partito comunista non vuol perdere la sua tradizione, la sua identità.

03-05-1977 Roma
Nella foto: Luigi Berlinguer e Aldo Moro. Di Per questo file non è stato specificato nessun autore. Per favore fornisci le informazioni relative all’autore. – Gad Lerner, Compromesso storico, quando la sinistra si convince di non poter governare, in gadlerner.it, 30 aprile 2013., Pubblico dominio, Collegamento
C’è una bellissima lettera che Tatò, il segretario di Berlinguer, gli scrive, non ricordo se nel ’77 o ’78, dicendo: “… in questa finanziaria non siamo riusciti a immettere elementi di socialismo…”. Questa frase è illuminante: Tatò, mentre il mondo precipita dentro una crisi che avrebbe portato al trionfo del neoliberismo, si domanda se nella finanziaria del ’78 c’erano elementi di socialismo! Quella era la cultura politica di questo grande partito. Rompere con l’ancoraggio con la sua tradizione significava perdere un’identità, e navigare in un mare incognito.
Berlinguer arriva fino al punto estremo della navigazione, arriva a dire che la Nato andava bene, che la forza propulsiva della Rivoluzione d’ottobre era finita. Però non fa il passo oltre questo limite, per il semplice fatto che la sua cultura politica (e dell’intero gruppo dirigente), non glielo consente. E infatti perché cade, nel ’79, il governo di unità nazionale? Non solo per il Serpentone monetario (come abbiamo detto sopra), ma cade perché la Nato chiede all’Italia di mettere i missili Pershing contro l’invasione sovietica dell’Afghanistan. e il Partito comunista non può accettare che in Europa si mettano i missili contro l’Unione sovietica.
Sono due esempi molto significativi dei limiti delle culture politiche. Quando noi parliamo di politica dobbiamo sempre pensare che la politica ha una sua dimensione “alta”. Gli uomini possono fare alcune cose, ma non tutti e non tutte, per il semplice fatto che le tradizioni, il peso, la forza che deriva loro dalla conduzione di un grande partito di massa, pone a questi uomini – a Moro, a Nenni, a De Martino, e anche a Berlinguer – una grande responsabilità. Cosa ne è della loro comunità politica? La posso distruggere, la posso mettere in discussione? Ecco, prevale in quel contesto la convinzione che si possa salvare il salvabile di quella storia. Ma in quel momento quegli uomini non possono sapere come andrà a finire.
Il 1979 e il ritorno del neoliberismo
Da questo punto di vista, quel ’79 è importantissimo. Il contesto nel quale operano i partiti politici italiani ha dei vincoli molto forti. Col secondo shock petrolifero c’è la percezione che la crisi non è più una bagatella, o, comunque, non è una cosa governabile con gli strumenti dell’ortodossia keynesiana ereditata. Bisogna inventarsene degli altri. In realtà questi altri strumenti ci sono, e sono quelli dei teorici del neoliberismo. I teorici del neoliberismo erano rimasti silenti. Milton Friedman scriveva le sue cose già negli anni ’40, ’50, ma l’ortodossia dominante ne aveva fatto una persona che stava ai margini. Non è un caso che il premio Nobel glielo diano nel 1974. È allora che la visione economica neoliberista torna al centro e, com’era accaduto al keynesismo negli anni Trenta, diventa immediatamente una ideologia, basata su due assunti fondamentali: 1) che tutti i tentativi dello stato di regolamentare il mercato sono la causa della crisi (come disse Reagan: “Lo Stato non è la soluzione, ma il problema”) e 2) che va fatta piazza pulita delle ideologie.
Si può vivere in un mondo postideologico, perché le soluzioni possono venire solo dal ritorno al libero mercato e al dominio dell’ortodossia economica.
Tutto questo accomuna tutti, anche partiti opposti. Del resto nella storia questo è accaduto più volte. Negli anni ’20, per esempio, l’assunto della base aurea dell’economia era fatto proprio tanto da Mussolini – che fa quota 90 -, quanto da Lenin, che recupera il valore monetario del rublo. Questi due personaggi, politicamente antitetici, avevano la stessa idea, cioè che se le monete non sono attaccate all’oro sono carta straccia. Poi Keynes spiegherà che non è vero, ma, a quel punto, Lenin non c’era più e Mussolini era ormai in un’altra fase.
Quindi, da questo punto di vista, Friedman e il neoliberismo diventano un’ideologia, esattamente come quella del keynesismo e come quella dell’imperialismo liberista del secondo Ottocento. Sono apparati ideologici che vengono assunti dalla politica. E così le coalizioni politiche che governano i paesi principali si spostano da coalizioni progressiste – Carter, la socialdemocrazia nordica, la Spagna, Soares in Portogallo, il governo di solidarietà nazionale – a coalizioni monetariste, che vincono con la Thatcher, con Reagan, con una Francia in cui c’è la coabitazione di destra con la sinistra e anche in Italia, dove, tutto sommato, il pentapartito è una coalizione che rompe con la tradizione precedente e cerca, a suo modo, di stare dentro questo nuovo mood internazionale.
È chiaro che il pentapartito non nasce solo dal “preambolo” di Donat Cattin (al Congresso Dc del 1980). Se lo guardiamo in prospettiva, quello che accade in Italia non è molto dissimile da quello che accade altrove. Le coalizioni monetariste che si formano, che governeranno l’Europa e l’Occidente fino alla fine degli anni Ottanta e agli inizi degli anni Novanta, sono il più grande portato di una rivoluzione dentro la crisi: una rivoluzione ideologica, una rivoluzione culturale e di strumenti.
La finanziarizzazione dell’economia
E qui veniamo allo strumento principale del neoliberismo di fine secolo: una riconsiderazione complessiva della teoria del valore. Non è possibile in questa sede soffermarcisi troppo, ma in base a questa riconsiderazione si stabilisce che non ci sono aree della produzione e della riproduzione sociale chiuse alla valorizzazione del capitale. Si rivede, cioè, uno dei capisaldi del compromesso progressista: dentro il welfare il capitale non entra, è lo stato che eroga. Al contrario, l’idea che tutto è valore e tutto è valorizzabile, quindi privatizzabile, diventa un grande strumento non solo di allargamento del capitale finanziario ad aree che fino ad allora erano rimaste proibite alla dinamica del capitale, ma di rottura di tutti i lacci e lacciuoli che impedivano la libera circolazione del capitale.
Nel giro di dieci anni, a partire dalla fine degli anni ‘80 – primi anni ’90, comincia ad emergere un dato che nessuno aveva previsto: una massa di capitale finanziario circolante nel mondo pari a quattro volte i prodotti interni lordi di tutti gli stati del pianeta. Un flottante finanziario di dimensioni enormi, tutto esclusivamente costruito su quella che viene definita “cartolarizzazione del debito”: i cittadini si indebitano, ma questi loro debiti non sono soltanto perdite per chi presta loro i soldi, perché attraverso la loro cartolarizzazione (tramite derivati finanziari) alimentano un mercato di prodotti finanziari ad alta redditività degli investimenti.
Nessuno immagina cosa sarebbe successo di tutta questa carta – lo scopriremo nel 2008 – ma, allora, questa roba regge la bolla espansiva, perché nella seconda metà degli anni ‘80 la crisi sembra in qualche modo risolta. C’è una ripresa. La Milano da bere è una Milano che costruisce case sulla bolla speculativa, non molto diversa, anche se su scala ridotta, da quella che si va gonfiando negli Stati Uniti e che si regge sullo stesso meccanismo: debiti finanziari, cartolarizzati, che poi diventano strumenti finanziari (bond), che vengono rivenduti ed entrano nelle pance delle banche e creano un valore fasullo.
C’è però un ulteriore dettaglio: questo valore fasullo è talmente potente da cominciare a mangiare la base industriale dei paesi. Le imprese diventano il segmento materiale di un procedimento e di un processo di finanziarizzazione dell’economia: per finanziarizzare gli investimenti mi compro, per esempio, anche chi fa le scarpe. Tutto quanto è subordinato al meccanismo della creazione del valore. Quando i banchieri, facendo sconvolgere i filosofi, dissero che il loro compito era quello di produrre valore per gli azionisti – una frase che fece il giro del mondo alla fine degli anni ’90 – si era prodotta esattamente questa mutazione.
A questo punto è chiaro che lo stato non ha più gli strumenti del governo della moneta, perché questi oramai sono pienamente nelle mani delle forze del mercato che li riproducono e li moltiplicano fuori da ogni regolamentazione, anzi sono così forti da imporre la caduta di ogni regolamentazione. Nel 1989 gli accordi di Maastricht teorizzano esattamente questo: gli stati europei devono progressivamente cancellare ogni ostacolo alla circolazione finanziaria.
L’Italia degli anni ’80. Il sostegno politico al reddito
L’Italia è dentro questo processo. Un po’ ci sta, un po’ cerca di sfuggire, perché non è nello Sme. Craxi lavora ancora con lo strumento della svalutazione competitiva, però è chiaro che questo strumento ha un difetto: la marginalizzazione progressiva dai processi di decisione del mercato mondiale a carico di chi lo mette in campo. Quindi lo si può fare fino a un certo punto, dopo il quale non è più vantaggioso per l’economia. In più, il sistema industriale italiano non regge il processo di delocalizzazione delle imprese. La grande industria di base (siderurgica, elettromeccanica, cantieristica), che è stato l’orgoglio e il vanto dell’Italia negli anni ‘50 e ’60, perde competitività a mano a mano che le imprese si delocalizzano nell’est Europa, in Asia, in Africa, e così via. E quindi c’è un tonfo del sistema, che si regge solo ed esclusivamente sull’uso clientelare – qui sì massimamente clientelare e partitocratico – della spesa pubblica.
Per studiare l’Italia degli anni ‘ 80 è interessante guardare al terremoto di Avellino. Salvo la piccola porzione di interventi virtuosi che il sindaco Valenti fa a Napoli, quel terremoto distribuisce 60.000 miliardi di risorse, che sono la causa principale di tre fenomeni. Il primo l’abbiamo visto in tutti i telegiornali: le strade che finiscono nelle case, le autostrade non finite, pezzi di palazzi buttati. Il secondo è l’assalto al territorio, cioè la produzione di cementificazione per sostenere imprese e redditi. L’hinterland di Napoli non sarebbe quello che è, se l’80% di quei 60.000 miliardi non fosse andato nelle mani di Scotti, di Gava, di Cirino Pomicino, a produrre l’elefantiasi della periferia napoletana, dove non c’è un albero, non c’è una strada, non ci sono fogne. Insomma, dove c’è quell’uso scriteriato del territorio, che poi avremmo pagato nei decenni successivi. Il terzo fenomeno avviene invece direttamente in seno all’opinione pubblica: l’idea che i redditi così sostenuti siano un diritto. Nell’Italia degli anni ‘80 abbiamo un’esplosione del sostegno al reddito, basato non sulla produzione, ma sul debito pubblico. Questo avviene soprattutto nelle regioni meridionali, ma non solo. Si crea così un circuito vizioso, nel quale la distribuzione clientelare delle risorse a famiglie, gruppi sociali, ceti arricchiti da una ricchezza artificiosa – che si trasforma poi in seconde case – produce un rapporto tra i cittadini e la politica dentro il quale allignano tutti i mali che in quel periodo cominciano a emergere.
La fine del paradigma antifascista
Avviene allora il primo tentativo di rompere il rapporto tra la repubblica e l’antifascismo, tra la repubblica e la Resistenza. Si tratta di un’operazione di politica culturale e di politica tout court fondata sull’idea, dotata di qualche dimensione riformatrice effettiva (si pensi ad Amato, a Bobbio, al gruppo di “Mondo Operaio”), che bisognasse ripensare il sistema politico italiano dentro un nuovo contesto di regole e di strumenti, che bisognasse, cioè, fare una grande riforma istituzionale e costituzionale per adeguare il sistema politico al cambiamento sociale ed economico dell’Italia.
È un tentativo di rottura del compromesso antifascista per dar vita a un altro compromesso, molto meno virtuoso, su cui rifondare la repubblica. Il primo passaggio è uno scostamento di date: l’affermazione che la repubblica italiana è fondata non sul 25 aprile, ma sul 18 aprile, quello del ‘ 48. Guardare la storia d’Italia alla luce di questo scostamento non è un fatto puramente formale, ma è un fatto sostanziale. Il 25 aprile del ’45 rappresenta infatti il compromesso che unisce le forze antifasciste uscite dalla guerra. Il 18 aprile del ‘ 48 rimanda invece alla frattura fra le forze “democratiche” e i partiti marxisti, comunisti e socialisti. Rileggere la storia d’Italia a partire da quella data significa la delegittimazione assoluta del partito comunista e, al contempo, la rilegittimazione della destra, delle forze legate al Movimento sociale italiano. Senonché il partito comunista rappresenta il 25% o il 30% degli italiani, nella destra ci sta il 7, l’8, il 5%, a seconda dei risultati.
Si tratta di una grande operazione. L’intervista di Ferrara, il ruolo di De Felice, l’uso che Craxi e molti degli intellettuali socialisti fanno del tema della Resistenza non è una cosa che riguarda gli storici, ma riguarda l’identità della repubblica, l’identità della nazione. Lì si pone in essere, in nuce, un’operazione che prenderà forza negli anni ’90, quando il centrodestra, costituito da partiti che con la tradizione dell’antifascismo non hanno nessun rapporto, porranno il problema dei fondamenti della “nuova repubblica”, che non sono più nell’antifascismo anche in virtù del fatto che i partiti antifascisti, nel frattempo, si sono squagliati come neve al sole.
È chiaro che questi anni ‘80 sono anni complicati, complessi, ma noi dobbiamo leggerli pensando a un’Italia inserita nel processo di globalizzazione. Un processo che ha effetti sul sistema politico, da un lato come diretta conseguenza di esso, dall’altro lato come resistenza di gruppi, di ceti, di interessi, ai processi di cambiamento in atto. Non dimentichiamo che imprenditori, partiti e sindacati saranno uniti nella difesa dell’industria pubblica, perché la difesa dell’industria pubblica è difesa dell’occupazione. Tutta la battaglia sul referendum della scala mobile dell’‘85 è emblematica della fatica che fa il mondo del lavoro ad abbandonare una delle grandi convinzioni, maturata negli anni ‘60 e rafforzata negli anni ’70, ovvero l’idea che il salario fosse una variabile indipendente del sistema economico, ancorato alla dinamica dei diritti e non invece al suo elemento cogente, la produttività.
Quindi la discussione sul punto della scala mobile, Craxi, il referendum, tutto questo nasconde al suo interno una dinamica storica che anche altri paesi stanno affrontando. Il processo attraverso cui si giunge ad affermare che il welfare non è più un diritto, ma diventa da un lato spazio della penetrazione della valorizzazione del capitale e dall’altro elemento da ridurre costantemente perché non ci sono le risorse per sostenerlo, accade in tutti i paesi, non solo in Italia.
Semplicemente in Italia accade, come sempre, con quella pennellata di corruzione che ci rende le cose più divertenti, più “tipiche”.
Il crollo del sistema
E siamo al crollo del sistema del 1992-93. Questo avviene per una ragione molto semplice: l’Italia non può più usare né la leva della spesa pubblica, né quella della svalutazione creatrice e competitiva.
Non ha più una lira.
Succede che i paesi saltino per aria. È successo, per esempio, in Argentina. L’Italia era sull’orlo del default. E la crisi diventa ancora più drammatica perché manca il decisore politico: perché tra il ‘92 e il ‘94 “tangentopoli” spazza via tutti i partiti politici. Questo aspetto è molto interessante, perché siamo l’unico paese in cui l’intera classe politica viene eliminata. In questo momento di radicale crisi di sistema riemerge però quella risorsa straordinaria del nostro paese che sono i tecnici di alto profilo nazionale. Il trio Amato, Prodi e Ciampi ne sono gli esempi più evidenti. Sono loro che avviano un processo di trasformazione profondo dell’economia italiana; loro che privatizzano, che mettono a posto i conti, che fanno stare l’Italia in Europa, che la fanno entrare nell’euro. Sono loro, cioè, che tengono l’Italia ancorata all’Occidente.
E sono loro che hanno la forza di fare quello che i partiti partitocratici non furono in grado di fare negli anni ‘80, cioè aumentare le tasse e, soprattutto, di farle pagare; perché in Italia le tasse si aumentano, ma – fino alla metà degli anni ’90 – c’era una larghissima fetta di cittadini che era formalmente esentata dal pagarle. Da questo punto di vista, il processo che viene messo in atto è sorprendente. Ed è sorprendente scoprire questa risorsa della repubblica, questo gruppo di grand commis (ma anche altri: Padoa Schioppa, Dini… l’elenco potrebbe essere lungo, basta pensare al primo governo Prodi), che provengono da una lunga tradizione di civil servant, che spesso ha le proprie lontane radici – si pensi a Ciampi – nell’azionismo. Se non avessimo avuto questa risorsa, e dei partiti capaci di capire che era una risorsa cui attingere, probabilmente la crisi politica italiana sarebbe stata profondissima.

Romano Prodi, Carlo Azeglio Ciampi e Giuliano Amato – fonte: http://www.carloazegliociampi.it/161?resource_3651=7212&relational_resource_3411=7212
Il “decennio riformista”
Quale scenario si apre, dunque, negli anni ’90? Dal punto di vista storico, si apre quello che Paul Lazard ha chiamato il “decennio riformista”: un decennio, cioè, di tentativi di riforme profonde della società italiana e dell’economia italiana. Pensiamo per esempio alle istituzioni. Il nuovo sistema di elezione dei sindaci, l’abbandono delle preferenze, la riforma elettorale (il famoso Mattarellum) sono tutti processi che vanno in direzione di una forte spinta riformista.
Già la questione del Mattarellum mette in evidenza, però, che non c’è riformismo effettivo senza riforma dei partiti e senza riforma delle istituzioni. Non si può fare. E nonostante il fallimento del tentativo di riforma della Costituzione – nonostante tutte le discussioni a riguardo – già il riformare il sistema dei partiti e il mettere in moto processi riformisti dentro l’economia – in direzione, soprattutto, della privatizzazione dell’industria pubblica – ha fatto in modo che l’Italia evitasse di precipitare dentro una spirale che l’avrebbe allontanata dall’Europa. Questo processo ha avuto certamente dei costi notevoli, per quanto riguarda i redditi, per quanto riguarda le chanches, per quanto riguarda gli issues, come si suol dire, di gruppi di interesse e anche di gruppi sociali molto ampi, ma ha anche avuto il merito, a mio modestissimo parere, di aver ricollocato l’Italia nell’unico ambito dove poteva dotarsi degli strumenti per reggere la spinta della globalizzazione.
Italia laboratorio di populismo
Certo, gli anni ’90 in Italia sono stati anche il decennio del neopopulismo. In alternativa alla soluzione che io chiamavo riformista, entra in campo pesantemente e fortemente la soluzione populista. Noi siamo stati il laboratorio di una soluzione populista molto prima di Le Pen, molto prima di altri paesi, ma lo siamo stati perché da noi più profonda era la crisi del sistema politico, più profonda era la crisi delle classi dirigenti, più profonda era la crisi del sistema economico, quindi più profonde erano le lacerazioni sociali che hanno spinto gran parte delle classi medie colpite dalla fiscalità, colpite dalla riduzione dei redditi, colpite dalla presa d’atto che la soluzione della questione meridionale si si era ridotta a un enorme strumento di distribuzione clientelare delle risorse, ad organizzarsi e a trovare nuovi partiti.
Di qui il successo di Bossi prima, e poi di Berlusconi. La questione della Padania, l’ampolla sul Po, sappiamo che sono tutte baggianate; non c’è bisogno di essere uno storico per capirlo. Quello che però è importante capire è perché in Italia, che è un grande paese democratico ed evoluto, si verifichi uno spostamento così consistente dell’opinione pubblica. Perché gli italiani hanno deciso di votare queste forze? Non è questione riducibile alla signora di Voghera, al controllo delle televisioni, alla videocrazia. Io non credo a questa spiegazione. I processi storici sono molto più complessi di questo. Il fatto che l’Italia diventi un laboratorio di populismo rimanda alle nostre lacune storiche, alle modalità con cui siamo stati nei trent’anni dello sviluppo e nei vent’anni della crisi, rimanda a come l’Italia ha attraversato i processi di globalizzazione e il superamento di quel trentennio di grande sviluppo.
E c’è sempre una ragione nazionale dentro processi che nazionali non sono. Infatti il populismo negli anni ‘90 e poi nel 2000 dilaga ovunque, fino a diventare – e questo sarebbe un problema su cui riflettere – elemento cruciale della partita nella più grande, evoluta e potente democrazia del mondo. Perché Berlusconi è molto meglio di Trump, non ci vuole molto a capirlo.
La sconfitta del riformismo
Nell’ultimo decennio il riformismo perde per una serie di ragioni che riguardano cose non fatte, cose fatte male e anche le cose fatte, cioè il fatto che le cose fatte hanno colpito degli interessi, che si aggregano, si coagulano.
Ovviamente si coagulano attorno al Berlusconi 2, che non è più il Berlusconi 1. Il Berlusconi neoliberale e liberista, il Berlusconi del no ai lacci e lacciuoli, diventa il Berlusconi 2: il Berlusconi delle corporazioni, degli interessi consolidati, dei gruppi di interesse. Basti pensare che le poche liberalizzazioni fatte in questo paese le ha fatte solo il centrosinistra e non il centrodestra, che doveva esserne il naturale sostenitore. Il partito di Berlusconi diventa il partito delle burocrazie pubbliche, il partito che difende lo statu quo. E questa difesa dello status quo è un grande catalizzatore di interessi nei ceti medi, soprattutto meridionali. Vi ricordate il 60 a 0 delle elezioni del ‘96 in Sicilia? Un risultato che non si può spiegare solo con la mafia. Certo c’è anche quella, ma c’è una catalizzazione di interessi reali.
Berlusconi non l’hanno votato solo i mafiosi, l’hanno votato professori universitari, docenti, elettricisti, autoferrotranvieri, preti, ospedalieri, malati, sani… l’hanno votato in tanti, l’hanno votato pezzi di società. E l’hanno fatto perché Berlusconi ritorna a garantire alle classi medie un patto di insindacabilità fiscale, un ritorno agli anni ’80, un patto fatto di una cosa detta ma non attuata – “bisogna ridurre le tasse” – e una parte nascosta, ovvero “se non paghi non ti veniamo a beccare”. Questo ha ovviamente effetti sulla spesa pubblica.
Infatti, a guardar bene, l’andamento della spesa pubblica ha una sinusoide interessante: quando c’è il centrodestra aumenta, quando c’è il centrosinistra diminuisce; il contrario di quello che lo storytelling corrente sostiene.
L’ultimo trentennio: una storia insegnabile
Questo insieme di processi, internazionali e nazionali, fa sì che l’Italia arrivi indebolita alla crisi. Arriva più debole di tutti gli altri paesi, perché Schroeder le riforme le ha fatte, la Francia le riforme le ha fatte, la Spagna le riforme le ha fatte, l’Italia no. Per questo, il tonfo dell’Italia è più profondo degli altri paesi e coinvolge, come era accaduto nel ‘76, il sistema politico. Lo travolge insieme alla crisi. Questo non accade in tutti i paesi. In Italia accade per il combinato disposto di dinamiche politiche, storiche ed economiche.
E siamo arrivati ai nostri giorni: il trentennio finisce in un profondo collasso dell’Italia e dell’Europa. Come se ne viene fuori? Su questo lo storico non ha niente da dire. Ma quello che vorrei passasse è che se noi guardiamo dalla prospettiva che vi ho delineato, la storia che ho raccontato è insegnabilissima. Io non ho parlato di politica, non sono entrato nel merito. Non occorre tramestare con i drammi della politica, parlare di schieramenti politici per parlare degli ultimi trent’anni. C’è, invece, tutto il corpus dei processi e dei fatti che riguardano la politica e la società e l’economia, che fanno di questo trentennio un pezzo della storia contemporanea simile a quelli che voi abitualmente insegnate.






















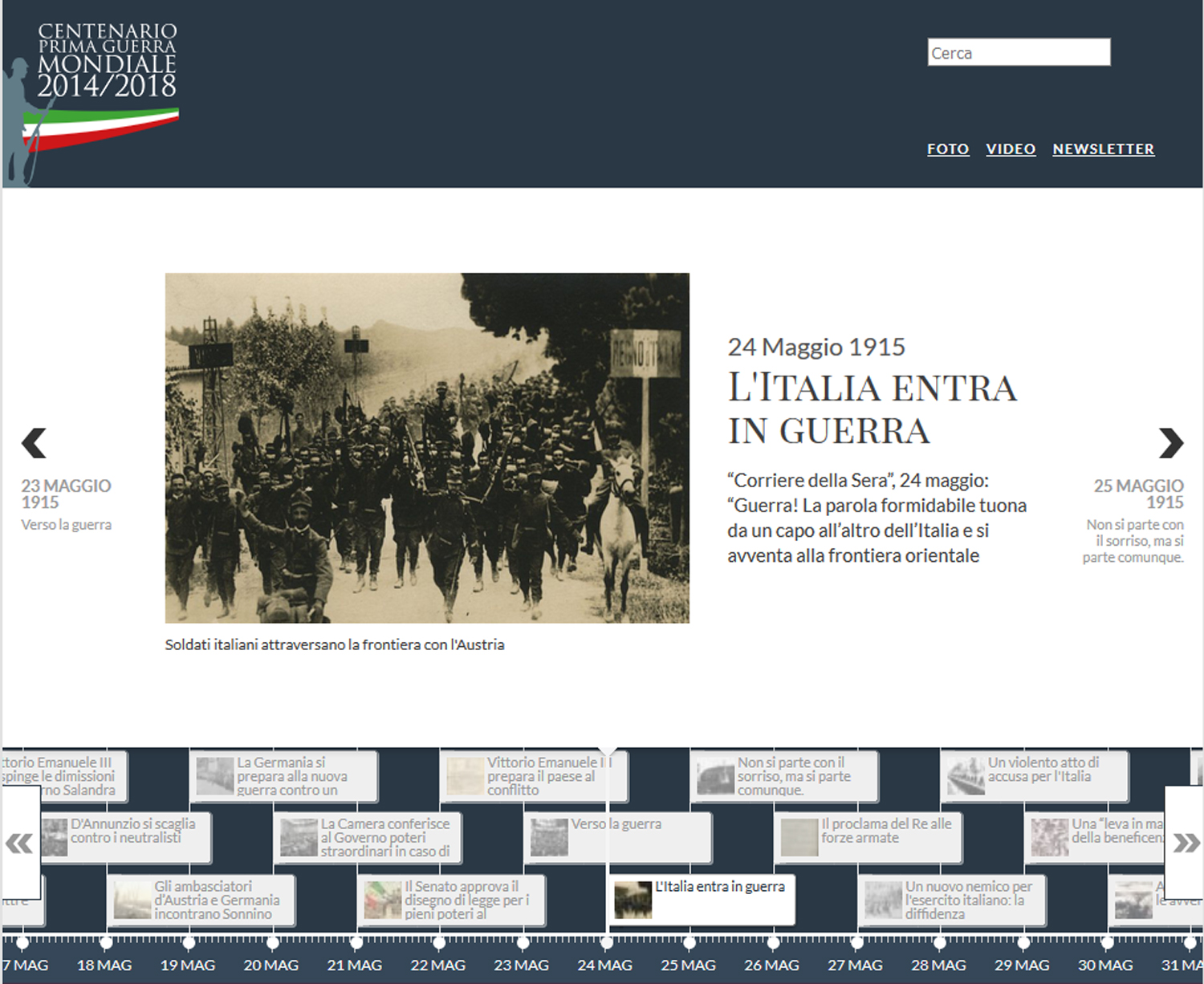
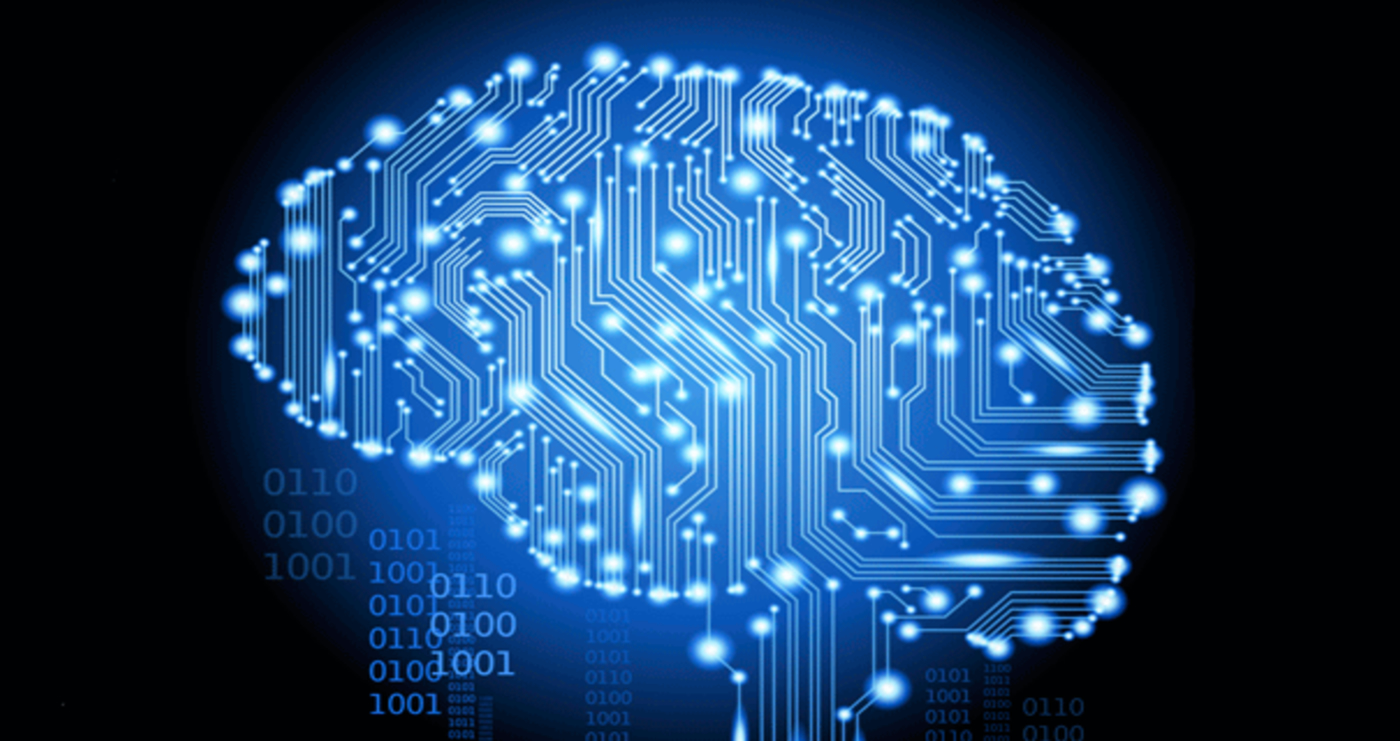

 Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini
Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Cassandra a Mogadiscio
Cassandra a Mogadiscio Identità di confine. Storia dell’Istria e degli istriani dal 1943 a oggi
Identità di confine. Storia dell’Istria e degli istriani dal 1943 a oggi La Resistenza delle donne
La Resistenza delle donne Se solo il mio cuore fosse pietra
Se solo il mio cuore fosse pietra Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini